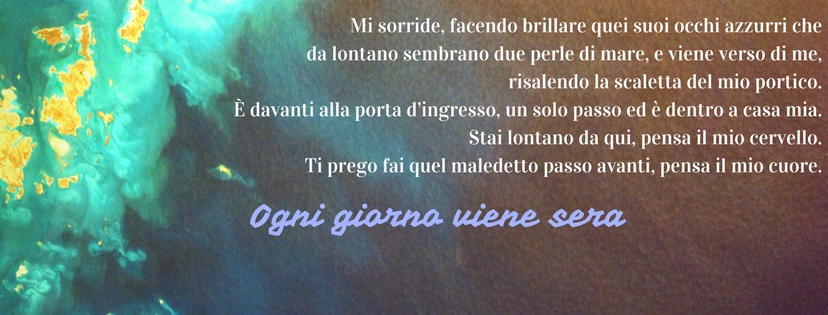Racconto

In questi ultimi tempi ho capito molte cose. Che siamo vite, innanzitutto, e in quanto vite abbiamo fasi da attraversare, crescite, riflessi che s’ingrandiscono dentro gli specchi. L’ultimo mese, ti dirò la verità, non sono stata poi così bene con te. È stato allora che ho capito che una fase – quella iniziale, la nostra splendida ingenua infanzia – si era appena conclusa. E, come sempre accade al bambino che per la prima volta si affaccia all’adolescenza, per un po’ ho avuto paura. Terrore, anzi. Terrore di vederti amarmi, di sentirmi la più forte, di amarti meno di quanto tu mi ami. Per molti giorni ho avuto paura di poterti fare ciò che avevo fatto a chi ti ha preceduto. Per molti giorni. È venuto Capodanno, siamo stati soli a casa tua, una cenetta a lume di candela. Da molto tempo non rivedevi i tuoi amici. Mi sono spaventata perché ho temuto di essere diventata il tuo tutto, e io non voglio esserlo.
Mi sono ricordata del Capodanno dell’anno prima, io e te a casa della nonna di Daniele, noi in quella stanza in cui non so chi era morto, al buio, la tua cravatta appesa alla maniglia esterna come fosse un rudimentale Do not disturb e poi Marco che apre la porta per sbaglio, capisce tutto, e noi che in coro gli diciamo Ciao, Marco e lui che ci saluta, imbarazzato, e poi va via. Il nostro primo Capodanno… com’è stato bello! O forse è vero che il ricordo sublima. Forse è vero che in quei momenti, tra i tuoi amici, fumando sull’orlo di un balcone che non era il mio, forse è vero che in quei momenti mi sono sentita a disagio. Ma ero a disagio anche sul tuo divano, quest’ultimo Capodanno, a pensare a quanto somigliavi al mio ex, in quel momento, a quanto fossi spaventata dal tuo diventare lui, inesorabilmente, giorno dopo giorno.
Ma credo che tu l’abbia capito. Fatto sta che hai ricominciato a vedere i tuoi amici, non mi chiami più troppo spesso, ci quasi-ignoriamo con dignità. E forse è vero che il tempo dei film di Rohmer con l’audio in ritardo e la cioccolata amara di Matisse è finito per sempre, ma è anche vero che crescere è parte di noi, siamo nati per diventare continuamente qualcosa di diverso da ciò che siamo. Siamo nati asindoti, eternamente tendenti al più o meno infinito. Ti amo in maniera più adulta eppure ti amo più di ieri. Sei il mio corpo, se ti bacio bacio le mie labbra, e se mi tocco mi tocco con le tue mani, cammino nel tuo quarantadue di scarpe o forse era quarantatré e la verità è che non ho mai saputo quanto calzi, quasi quanto tu non hai mai conosciuto la taglia dei tuoi pantaloni e nei negozi d’abbigliamento devi spogliarti tra le grucce gravide per scoprirlo. Il tempo ci ha resi più morbidi: non sbattiamo troppo agli spigoli del nostro essere diversi – speculari – ci accarezziamo aggredendoci. È una nuova fase – questa – la nostra adolescenza, il nostro tempo ribelle, sconsiderato, forse un pochino depresso. È in questa fase che le radici penetrano nel terreno. È questo il momento che definisce ciò che saremo, non l’infanzia, che con la sua dolcezza velata di euforia è servita a metterci al mondo, e poco di più. Mi piace, immaginarci come una sola vita. È come se ci avessi portati in grembo per nove mesi, e un po’ è stato così, perché per nove mesi ti ho amato di nascosto.
Tra due giorni ho l’esame di storia della tradizione classica con l’uomo che è stato il tuo professore di italiano al liceo per quattro anni. Ironia del destino. Non l’avrei mai saputo, se non fossimo stati insieme adesso, eppure quell’uomo, lo stesso che mi ha messo un trenta tondo tondo allo scritto e che fra due giorni m’interrogherà, quello stesso uomo era colui che ti diceva che nei compiti in classe correvi troppo, che i tuoi pensieri erano più veloci di te, come mi raccontasti una di quelle volte che tornavamo insieme dalla scuola di musica. Quando arriva la fine del sabato, è come se un pezzo di me si spegnesse con la cicca di sigaretta che butti sempre prima di averla consumata fino alla fine. Il sabato è il fondo della settimana, ed è il mio obiettivo. Vivo, per il sabato. L’università, gli esami, lo studio, e poi il pianoforte, il trucco sempre un po’ pesante della mia nuova professoressa… tutto è solamente una strada verso di te. Verso il nostro sabato. Verso il momento in cui scendo dal treno e leggo il nome della tua città in bianco sul cartello blu e ricordo il mio primo momento lì, il mio primo passo sul marciapiede della stazione. E allora mi accendo una sigaretta – adesso le fabbrico io, con una macchinetta, tabacco Lucky Strike da 15 g – e vedo il fumo volarmi via dalle labbra come se qualcuno lo stesse tirando e poi vedo te. La tua testa compare e scompare dal muretto come uno yo-yo impazzito ed è lì che inizia il mio sabato, l’obiettivo della mia intera settimana, e tu attraversi i binari saltellando, le tue Timberland contro il legno e le pietre, e poi sono dentro il tuo abbraccio e hai sempre un sapore un odore diverso da quello della settimana precedente. Sei la mia casa, cammini con me ancorato alle mie spalle. Sei tutte le stanze nelle quali muoio dalla voglia di entrare, e ti tengo chiuso a chiave il più possibile per non consumare troppo presto la gioia che proverei nell’aprirti.